“L’uomo – ha scritto Carlo Maria Martini – è un perenne insoddisfatto, anche quando è apparentemente appagato di tutto. E questo avviene perché la vita di ciascuno di noi ha nostalgia di potersi riavvicinare all’Amore che l’ha generata” (Martini 2012, 840).
È così: molto spesso siamo presi da una inquietudine di fondo, non riferita a qualcosa di episodico, ma per così dire più strutturale. Nonostante proviamo a distrarci vedendo un amico, facendo yoga o trascorrendo del tempo su internet, tale sentimento di fondo – simile, ma non uguale, alla tristezza – ci accompagna ostinatamente. Si cerca di dimenticarlo, facendo finta di nulla, ma rimane lì, come un ospite misterioso. Molti di noi continuano a condurre la propria esistenza tra alti e bassi, abituati ad ignorare questo abitante silenzioso della nostra interiorità.
C’è anche un altro modo per affrontare l’ospite misterioso ed è di mettersi di fronte a lui, di provare a “vederlo” bene, di porsi in ascolto di ciò che vuole dirci. Certo, andare incontro al mistero è più facile a dirsi che a farsi. In fondo, però, quale alternativa rimane? Possiamo davvero pensare di trascorrere l’intera nostra esistenza, sormontati da una inquietudine che non ci permette di esprimere appieno il nostro potenziale?
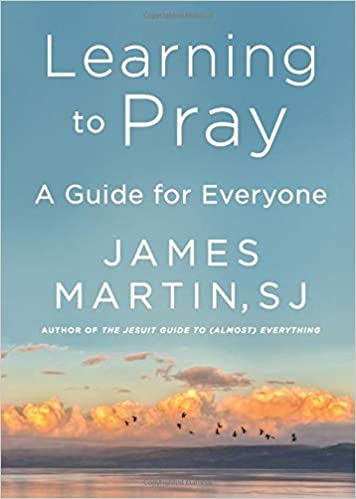
Iniziare questo percorso alla scoperta di questa parte misteriosa di sé coincide con l’avvio della vita spirituale. A questo livello, la naturale e fisiologica incertezza cede il passo ad una sorta di riverenza[1], un atteggiamento di fiducioso rispetto nei confronti di ciò che, seppure ancora misterioso, in qualche modo ci convoca alla sua presenza. Il convocare, se vogliamo essere coerenti con la sua etimologia, significa “essere chiamati per nome”. Dunque, ricapitolando, c’è una parte misteriosa di me, che mi sollecita a muovermi nella sua direzione e, per farlo, mi chiama per nome.
Questa chiamata corrisponde non ad una dinamica impersonale, ma a qualcosa di personale. “Io” mi sento chiamato.
James Martin, un gesuita americano, già autore di saggi sulla vita interiore, alcuni dei quali pubblicati in italiano come la celebre Guida del gesuita… a quasi tutto (San Paolo), ha appena pubblicato Learning to Pray. È un libro in cui si riflette esattamente su che cosa sia questa “chiamata” che viene a colmare la nostra inquietudine. Per Padre Martin questa chiamata ha un nome: preghiera.
Qui veniamo un po’ colti di sorpresa: generalmente pensavamo che la preghiera fosse una reiterazione di formule o qualcosa destinato ad un “pubblico” specifico. È, infatti, difficile negare che nell’immaginario contemporaneo, “attori” della preghiera siano persone di una certa età, inclini al bigottismo o alle inalazioni di incenso.
Nelle parole di Padre Martin, invece, la preghiera è una specie di lotta che riguarda tutti e i cui esiti non possono essere dati per acquisiti, tanto meno ritenuti un possesso da esibire come un trofeo, come alcuni credenti impunemente fanno, pensando che nessuno si accorga del danno alla vera fede da essi inferto.
Quali sono, secondo Padre Martin, gli altri elementi da tenere presente quando parliamo di preghiera?
1) Pregare è flessibile. Sembra uno slogan, ma è un modo per indicare che si tratta di sviluppare una relazione personale con Dio. La preghiera è per tutti. Cogliere questo aspetto della preghiera è una esperienza in grado di cambiare la vita;
2) Perché dovremmo pregare? Dio vuole conoscerci ed avere una relazione con noi. Il nostro desiderio di affrontare l’inquietudine ne è la prova. Nel profondo di noi stessi, c’è un desiderio naturale di completamento, possibile solo ponendosi in relazione con colui che ci ha creati.
3) Quante concezioni esistono della preghiera? Ne esistono molte. Secondo Giovanni Damasceno, un monaco vissuto in Siria nell’ottavo secolo, la preghiera è “l’elevazione della propria mente e del proprio cuore a Dio o la richiesta di cose buone”. Secondo questa prospettiva, la preghiera è un approccio dal basso. Pregando, noi facciamo memoria della nostra posizione nell’ordine cosmico. Ecco perché nella definizione di Giovanni Damasceno si parla di “elevazione”. Un’altra definizione risale a Teresa d’Ávila, una monaca spagnola del XVI secolo secondo cui la preghiera è niente “altro che una stretta condivisione tra amici”. Immaginate – dice Padre Martin – di ritrovare una vecchia amica a cena. Non vi vedete da molti anni, ma quando vi sedete, voi dite: “Scusa, ho solo cinque minuti: inizia a parlare!”. Non sarebbe assurdo? Bene, nei confronti del nostro più grande “amico”, Dio, noi ci comportiamo nello stesso modo. Ecco il motivo per cui dovremmo trascorrere con Dio più tempo di quello solitamente riservatogli. Un terzo modello di preghiera risale a Teresa di Lisieux, vissuta alla fine dell’Ottocento in Francia. Per Teresa la preghiera è amore e intimità. Per la precisione è: “uno slancio del cuore, uno sguardo verso il cielo e un grido di riconoscimento e di amore, che abbraccia sia la prova che la gioia”.
Quando si prega, si guarda verso il cielo e, in modo misterioso, è proprio lì che troviamo noi stessi. Qui Teresa attinge al Salmo 42 dove è scritto che “Un abisso chiama l’abisso”. Si tratta di un riconoscimento liberatorio. Infatti, quando si è pienamente riconosciuti, si può parlare liberamente e apertamente.
Quando dopo un viaggio si ritorna a casa si ritrovano le cose familiari. Non è infrequente che esse siano viste con uno sguardo un po’ diverso da quello che avevamo prima di partire.
Per certi versi, le prospettive dischiuse da Learning to Pray assolvono la stessa funzione: non ci sentiamo più “soli” di fronte all’inquietudine che accompagna le nostre giornate. Scopriamo che esse sono costitutive del nostro stesso essere e che, in qualche modo, non ostruiscono ma anzi ci instradano verso una vita di pienezza per il tramite di una relazione personale con ciò da cui veniamo.
La tradizione, quella stessa tradizione da cui è oggi di moda prendere le distanze, ha dato a questa relazione personale il nome di preghiera. Essa è la forma assunta dal nostro essere nomadi sul cui valore proprio Carlo Maria Martini ha scritto riflessioni profonde: “Nomadi. Questa è la condizione reale, oggettiva, di ognuno di noi, di ogni famiglia, di tutti su questa terra. Ma siamo capaci di vivere così? Viviamo come pellegrini o come gente arrivata, sistemata? Come forestieri o come gente che ha messo qui le radici, come se non dovesse mai più andare via? Come zingari in una tenda, o come signori che cercano solo di stare bene, comodi, tranquilli, senza pensare al tempo che passa, al bene che resta, ai fratelli che tendono la mano?” (Martini 2012, 840).
Riferimenti bibliografici
Martini, Carlo Maria. 2012. Le ragioni del credere: scritti e interventi. Milano: A. Mondadori.
Pontiggia, Virginio, Carlo Maria Martini, e Cattedra dei non credenti. 2015. Le cattedre dei non credenti.
[1] È ancora Martini a segnalare che: “La preghiera appare come un continuo atto creativo, un accendersi continuo della speranza. Quando ci si apre alla realtà e ci si abbandona alla meraviglia, alla riverenza, si può guardare quella realtà con occhi pieni di amore e allora la si ringrazia e la si loda perché esiste” (Pontiggia, Martini, e Cattedra dei non credenti 2015, 190).
