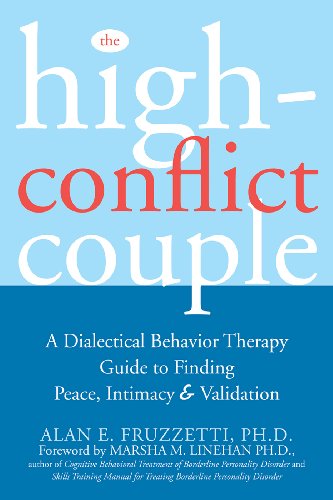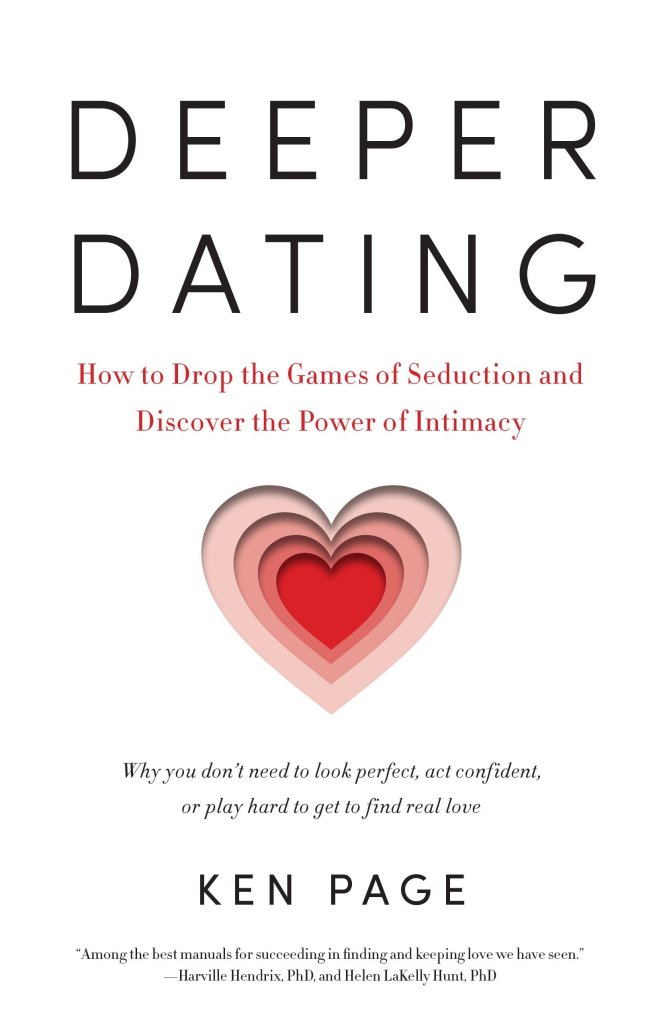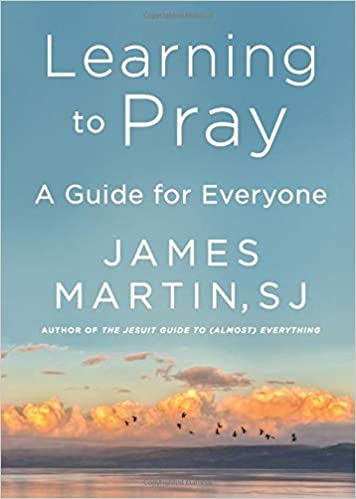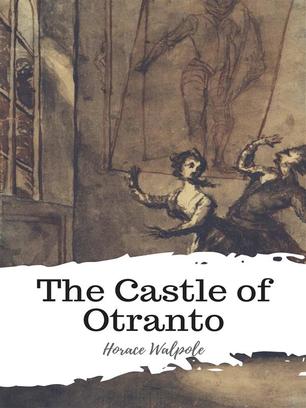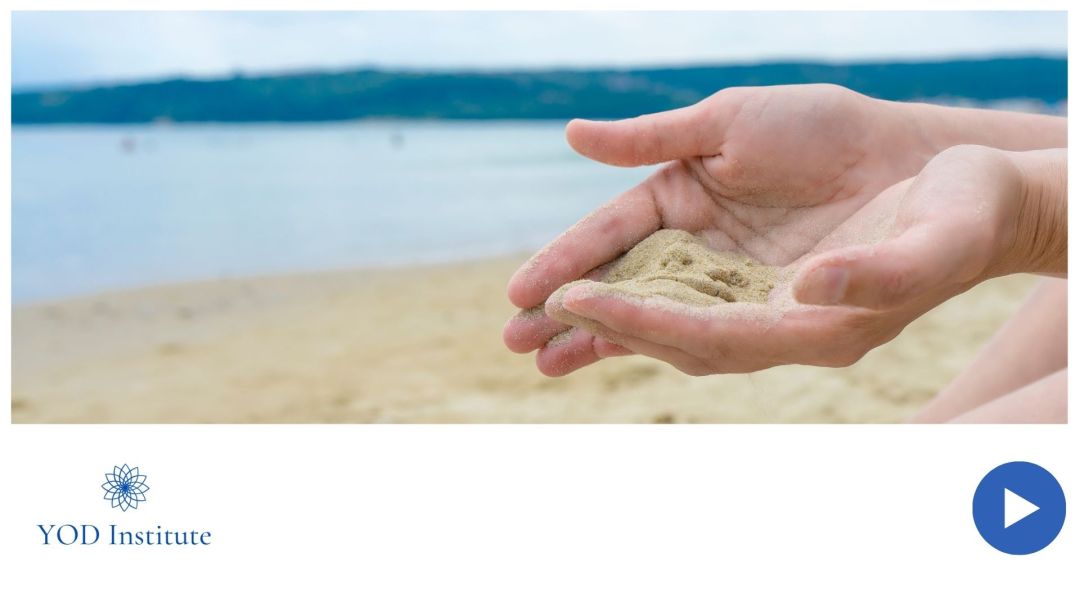Quante volte ci hanno detto che siamo troppo generosi? Che non ci risparmiamo mai? Si tratta di un complimento, che in realtà segnala anche un problema: non sapersi dare dei limiti. E così sulla scia di una non del tutto corretta interpretazione del multitasking, sia che si tratti della vita di relazione sia che si tratti del lavoro, siamo come una fontana a cui tutti attingono senza limiti.
Ancora oggi, nella struttura di molti piccoli centri, nella piazza principale è collocata una fontana. È la classica “fontana del villaggio”, la fonte a cui tutti gli abitanti andavano per attingere l’acqua senza cui la vita non era possibile. La presenza della fontana era possibile anche perché tutto il villaggio si prendeva cura che il corso del fiume potesse scorrere liberamente, senza essere ingombrato dai rami degli alberi che, cadendo, inevitabilmente finivano con l’occupare il letto dei ruscelli vicini. In altri termini, c’era equilibrio, c’era una relazione armonica che permetteva alla fontana di essere fonte di vita.
Ovviamente, non c’è niente di male nell’improntare la propria esistenza ad una generale generosità. Tuttavia, quando tale scelta scaturisce dalla mancata tutela delle proprie prerogative e dei propri legittimi bisogni, allora si va incontro ad una postura sbilanciata. È questa la ragione per cui occorre non nascondere le proprie esigenze nel tentativo di giungere ad un rapporto equilibrato tra le proprie esigenze e quelle degli altri.
Quali sono i segnali dai quali ci possiamo accorgere che abbiamo bisogno di limiti?
Bene, riflettete per un momento su alcune domande. Vi sentite spesso stressati, sopraffatti o esauriti dalla quantità di lavoro che dovete fare? Trovate che fate fatica a dire di no alle richieste di amici, familiari e colleghi di lavoro? Vi ritrovate mai ad evitare certe persone che non vi fanno sentire a vostro agio?
Se avete risposto sì a una di queste domande, allora potreste avere un problema di limiti. Questo perché, per quanto diversi possano sembrare questi problemi, in realtà si riducono tutti allo stesso problema fondamentale: hai permesso ai tuoi bisogni di passare in secondo piano rispetto a quelli di qualcun altro. I limiti, quindi, consistono nel farsi valere per se stessi. Avere dei limiti sani significa poter contare sulle persone della tua vita per trattarti in un modo che ti faccia sentire a tuo agio.
Quando pensiamo ai confini, quelli che ci vengono in mente per primi sono i confini fisici del nostro corpo e dello spazio personale. Ma i confini fisici rappresentano, in realtà, solo un tipo di confine. Per esempio, abbiamo anche limiti sessuali, che riguardano la limitazione di argomenti di conversazione inappropriati, battute a sfondo sessuale e altri comportamenti che non siamo disposti a tollerare.
Poi ci sono i limiti intellettuali ed emotivi, che riguardano il rispetto delle nostre opinioni e dei nostri sentimenti da parte degli altri, anche se non sono d’accordo con noi. Abbiamo anche dei limiti materiali, che riguardano il modo in cui gli altri usano i nostri beni. E, infine, abbiamo limiti di tempo, che riguardano la garanzia che gli altri capiscano il valore del nostro tempo.
Certamente, molti di questi limiti sono codificati nella cultura, come lo spazio personale, quindi non dovrebbe essere necessario dichiararli. Tuttavia, altri confini sono più individuali, e sono quelli che dobbiamo comunicare. Per esempio, quando incontri qualcuno per la prima volta, potresti dover fargli sapere che sei più uno che stringe le mani che uno che abbraccia.
Naturalmente, stabilire dei limiti non è sempre facile. Ci preoccupiamo di essere visti come soffocanti, bisognosi o troppo sensibili. Potremmo anche preoccuparci di danneggiare la relazione rendendo le cose imbarazzanti.
Ma, a lungo andare, non porre limiti è controproducente.
Se permettiamo agli altri di calpestare continuamente i nostri confini, la qualità delle nostre relazioni inevitabilmente diminuirà.
Quindi, sì, porre dei limiti può essere scomodo. Ma, alla fine, il disagio a breve termine è un piccolo prezzo da pagare per avere relazioni funzionali e a lungo termine.