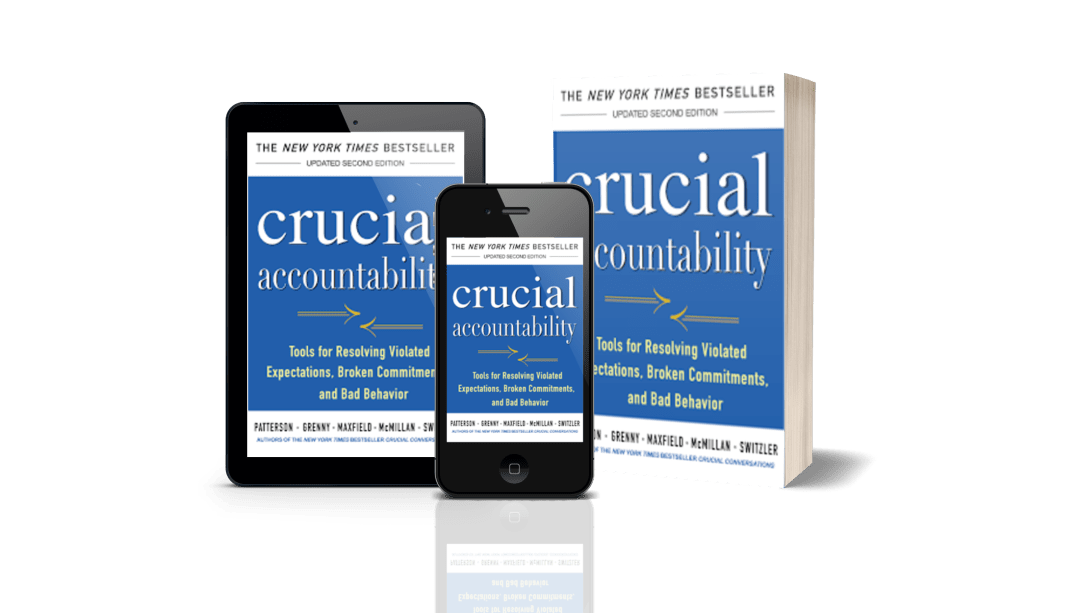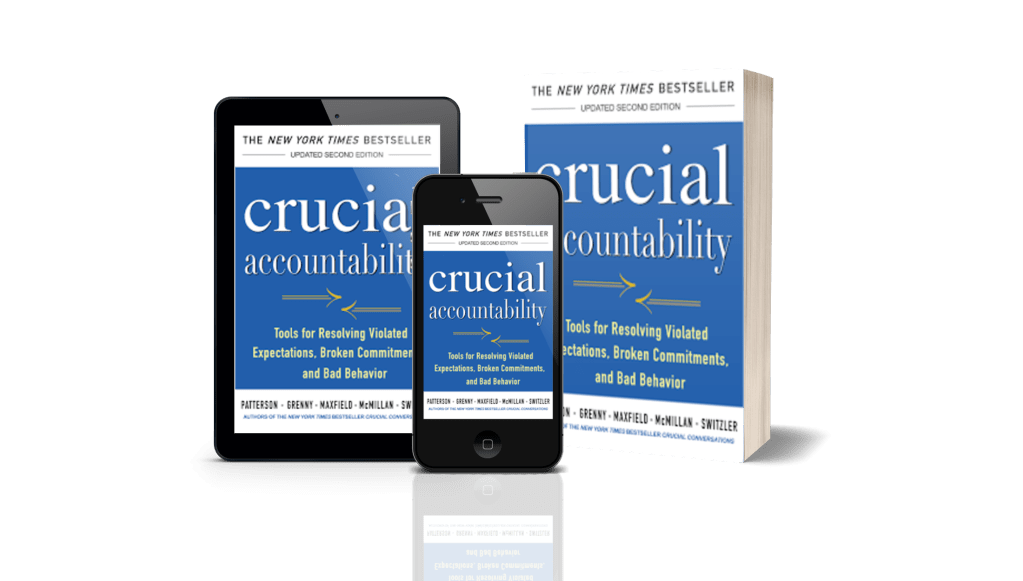
Le nostre domande al testo
1. Perché alcune comunicazioni, soprattutto nella vita di coppia e nella vita lavorativa non funzionano? È vero che c’è un errore – il cosiddetto “errore fondamentale di attribuzione” -che compiamo senza accorgercene?
2. Il rispetto e l’attenzione nei confronti dell’altro sono due elementi decisivi per la buona riuscita di una comunicazione. Eppure, sono anche le due dimensioni più trascurate. Come possiamo averne maggiore consapevolezza?
3. Uno dei modi più incisivi, per indurre qualcuno ad agire è di evidenziare le conseguenze del suo agire di cui potrebbe non essere consapevole.
4. Nonostante tutti gli sforzi, comunicare continua ad essere difficilissimo. È il segno che ci sono “barriere” invisibili. In quei casi, continuare a concentrarsi esclusivamente sui contenuti del nostro comunicare è perfettamente inutile.
5. Senza che ce lo aspettiamo, il clima di uno scambio comunicativo può improvvisamente mutare. Sappiamo come comportarci in quei casi?
6. Sappiamo fare attenzione alle emozioni del nostro interlocutore? Sappiamo “leggere” il suo linguaggio del corpo?
1. L’errore fondamentale
Immaginate che un uomo voglia discutere di una promessa che la sua ragazza non ha mantenuto. Tuttavia, la discussione degenera subito e i due iniziano ad urlare. Lui sostiene che lei non aveva intenzione di mantenere la promessa. Vedendo la reazione del fidanzato, lei pensa di avere una buona ragione per lasciarlo. La comunicazione è impossibile. Siamo di fronte ad un problema che gli autori del libro chiamano di “accountability”, cioè la responsabilità. Il punto è: per comunicare bene, bisogna evitare le supposizioni.
C’è un errore che comunemente commettiamo: è il cosiddetto “errore fondamentale di attribuzione”. Si tratta della tendenza ad assumere che la causa del comportamento sbagliato degli altri è che sono “imperfetti”.
Di fronte ad un comportamento altrui che ci lascia interdetti, noi formuliamo un giudizio negativo prima ancora di aver ascoltato ciò che gli altri hanno da dire. Pensate ad una donna sorpresa a rubare medicine. Qual è la cosa che ci viene immediatamente in mente? Quella donna è disonesta! Ma cosa succederebbe se considerassimo altre possibili motivazioni di quel gesto? E se la donna stesse rubando le medicine perché ha un familiare gravemente malato e lei non può permettersi medicine costose? Se vogliamo che le conversazioni vadano a buon fine, dobbiamo silenziare le storie negative che in automatico ci raccontiamo sugli altri.
2. Rispetto ed attenzione
Ci sono due cose principali che contribuiscono a sentimenti di insicurezza durante una conversazione di responsabilità.
La prima è la mancanza di rispetto, che si manifesta nel tono, nel modo di parlare e persino nel linguaggio del corpo. La seconda è la mancanza di attenzione per gli obiettivi e gli interessi dell’altra persona.
Per prima cosa, affrontiamo il rispetto. Questo inizia con il modo in cui vedete gli altri. Se pensate che siano persone ragionevoli e rispettabili, è probabile che vi avviciniate a loro come tali. Anche chiedere il permesso di discutere un problema dimostra rispetto, specialmente quando si trattano argomenti delicati o si parla con chi ha più autorità. Occorre avere la massima considerazione per gli interessi degli altri. Solo quando tale considerazione sarà effettiva, la conversazione di responsabilità potrà iniziare.
Per fare questo con successo, cercate di riferire i fatti, senza ricorrere ad accuse o conclusioni. Spiegate il divario tra ciò che vi aspettavate e ciò che è realmente accaduto. Poi aggiungete le vostre conclusioni, usando frasi provvisorie come “pensavo” e “mi chiedevo”. Questo linguaggio segnala che le tue conclusioni potrebbero essere sbagliate e che sei interessato a conoscere la posizione dell’altra persona.
3. Conseguenze
Molte persone sentono la parola “conseguenze” e immaginano cose come la punizione o il licenziamento. Ma usare le conseguenze per motivare non significa necessariamente ricorrere alle minacce di punizione. Tutte le azioni e i comportamenti hanno le loro conseguenze naturali. Per esempio, un uomo che fa costantemente battute sarcastiche a sua moglie finirà per allontanarla. Attirando l’attenzione sulle conseguenze naturali delle azioni di qualcuno, potete spingerlo a fare la cosa giusta.
Durante la vostra discussione sulla responsabilità, evidenziate le conseguenze naturali di cui l’altra persona potrebbe non essere consapevole. Queste includono benefici a lungo termine che valgono lo sforzo a breve termine, risultati che si allineano con i valori della persona, o problemi futuri collegati al suo comportamento attuale. Potete anche descrivere come altre persone sono influenzate negativamente dalle loro azioni. Mentre spiegate tutto questo, permettete all’altra parte di condividere il suo punto di vista. Potrebbero illuminarvi con conseguenze a cui non avevate pensato, il che potrebbe cambiare la vostra opinione.
4. Barriere
A volte, le discussioni sulla responsabilità rivelano che ci sono delle barriere che impediscono alle persone di soddisfare le aspettative. Quando questo accade, rivolgete la vostra attenzione alla rimozione di queste barriere in modo che possano portare a termine il loro lavoro. Ma non dovete affrontarlo da soli. Infatti, coinvolgere gli altri è un passo importante, che vi aiuta a capire gli ostacoli dalla prospettiva delle persone più vicine. E quando le persone contribuiscono a trovare soluzioni, si impegnano di più ad attuarle.
5. Gestire l’inaspettato con la flessibilità
Non sarebbe fantastico se tutto andasse secondo i piani? Sfortunatamente, non è così che funziona il mondo, comprese le conversazioni di responsabilità.
Certo, si può andare pronti a motivare e risolvere i problemi, sapendo esattamente di cosa si vuole discutere. Poi, di punto in bianco, salta fuori qualcosa di imprevisto – un problema ancora più grande, forse, o una reazione esplosiva dell’altra persona.
Sappiamo che il clima è importante per una discussione produttiva, ma come gestire un cambiamento di clima inaspettato?
La risposta sta nella capacità di essere flessibili. Iniziate spiegando che state cambiando l’argomento e che tornerete alla questione originale più tardi. Pensate a questo come a mettere un segnalibro nella conversazione.
Dopo aver annunciato il cambiamento, gestite il nuovo problema nello stesso modo in cui avreste affrontato quello originale. Stabilite la sicurezza, spiegate le conseguenze naturali ed esplorate le potenziali barriere e soluzioni. Potete poi rituffarvi nel problema originale, o tornarci un’altra volta.
6. Le emozioni intense
Se sorgono emozioni intense, scoprite cosa le sta causando in quel momento. Questo vi aiuterà a gestirle efficacemente in modo che la conversazione possa continuare. Chiedete cosa sta provando l’altra persona e perché. Gli altri potrebbero dire che stanno bene, ma il loro linguaggio del corpo e il loro atteggiamento suggeriscono il contrario. Fai notare questa incongruenza e incoraggiali ad aprirsi. Quando condividono le ragioni dietro le loro emozioni, ripetete quello che hanno detto con le vostre parole. Parafrasando, rendete chiaro che state ascoltando e allo stesso tempo avete la possibilità di chiarire qualsiasi cosa abbiate frainteso.