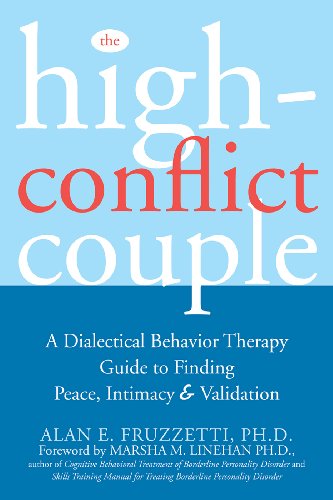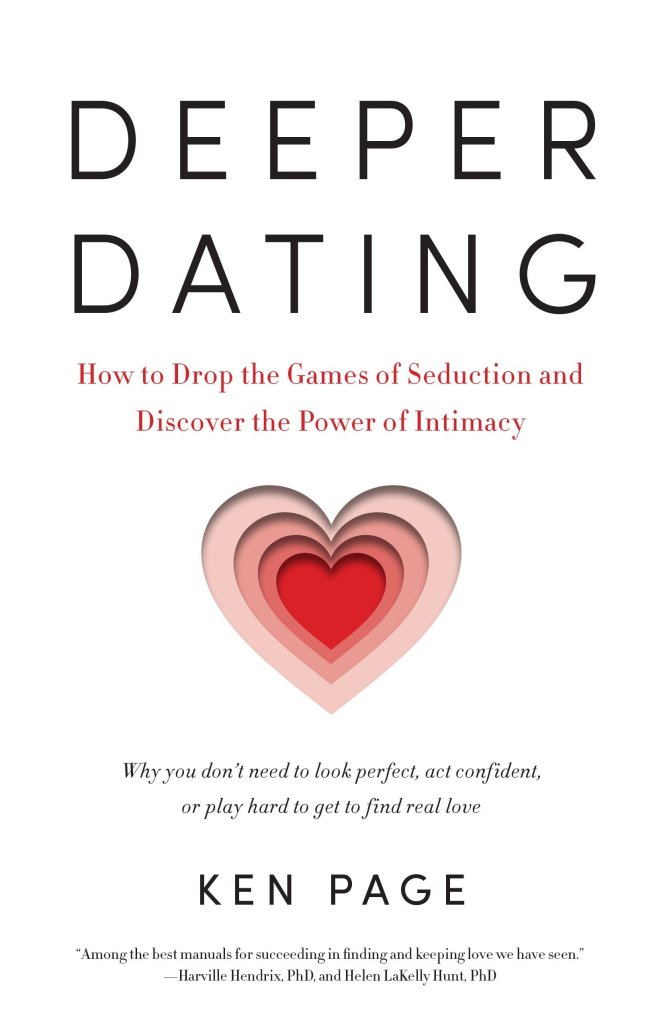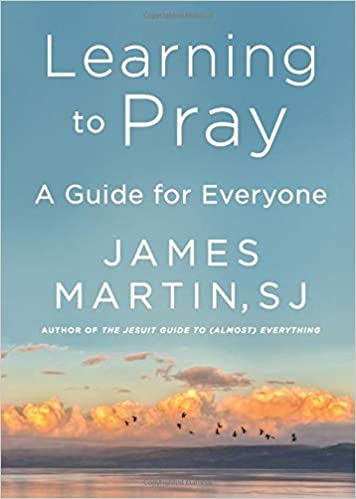1. Un peso sulla testa
Non è infrequente sperimentare un senso di sopraffazione, come se circostanze, occupazioni e preoccupazioni avessero eroso ogni aspetto della nostra vita. Sì, forse avremmo proprio bisogno di quella vacanza che abbiamo così a lungo desiderato, ma lo stesso indugiare su quella idea, invece di darci sollievo, ci riporta alla mente i problemi da cui vorremo provvisoriamente allontanarci. Sembra un vicolo cieco.
E così, si continua a lavorare o ad essere presenti laddove gli impegni lo richiedano, ma senza una reale spinta. Più che agire, è come se subissimo le nostre stesse azioni.
Sembra davvero difficile tenere insieme in modo armonico due aree della nostra vita, professione e famiglia. In alcuni casi, è come se non si dessero alternative: o lavorare o stare con i figli. In realtà, dividersi tra questi due ambiti è solo una parte del problema perché, se anche riuscissimo ad armonizzare la nostra presenza in entrambi, vi sarebbero comunque aree dalle quali ci saremmo tagliati fuori. Mi riferisco alla dimensione personale, a quella fisica, all’ambito intellettuale, emozionale e spirituale.
Esiste, infatti, una dimensione più squisitamente personale che non dovremmo accantonare: essa coinvolge i nostri hobby e le attività che sentiamo essere importanti per noi stessi. Anche dedicarsi del tempo, perfino per non fare niente o per andarsene a zonzo senza una particolare meta, rientra in questa fetta personale. Poi, c’è la fetta fisica: prendersi cura del proprio corpo, camminare, nuotare, fare fitness, ma anche nutrirsi con cura, dando ascolto alle proprie esigenze alimentari. La terza dimensione, la terza fetta, è quella intellettuale: consentire alla nostra curiosità di manifestarsi. Prendersi il tempo per leggere quel libro che ci aspetta sul comodino o partecipare ad uno spettacolo o ad una mostra. Quarto ambito cui prestare attenzione è la fetta emotiva, il modo in cui sentiamo noi stessi. Quando è stata l’ultima volta che avete scritto sul vostro diario? Quando vi siete soffermati a riflettere su come vi siete sentiti in seguito ad un determinato evento? L’ultima dimensione, la fetta spirituale, include le cose in cui profondamente crediamo, le convinzioni profonde o anche la fede religiosa.
2. La vita come una grande torta

David J. McNeff in The Work-Life balance Myth ha proposto di immaginare che ogni ambito rappresenti una fetta di una torta ideale. Essere in equilibrio, vivere bene, significa prendersi cura di ciascuna di queste fette di torta.
Da un lato, non è facile porsi in ascolto di questa proposta. Siamo, infatti, convinti che la complessità dell’umano sia poco riducibile a spiegazioni così schematiche. Chi si ritiene più sgamato, poi, non potrà che considerare con aria di sufficienza simili proposte, ritenendole semplicistiche. D’altro canto, è pur vero che il lungo indugiare sulla ricerca della migliore teoria possibile, allontana l’adozione di soluzioni concrete. Una cosa sembra certa: rimanere imbambolati a vivere il disagio di una vita sotto sforzo è sicuramente sbagliato. Vale dunque la pena di considerare ogni opzione sul campo, anche il “metodo delle sette fette” di McNeff, forse con uno sguardo più benevolo. Ma poi, siamo davvero sicuri che la proposta del coach americano sia così semplice da attuare?
3. Una vita bilanciata
Dunque, una vita bilanciata prevede che ogni giorno riserviamo un’attenzione consapevole a sette aree. Ora, giunti a questo punto, si presenta una obiezione fin troppo semplice: se già facciamo fatica a tenere insieme due tra queste aree, cioè la famiglia ed il lavoro, come è pensabile raggiungere un equilibrio allargando lo spettro delle attività invece di restringerlo?
Il punto è – spiega McNeff – che l’essere umano può volare alto, cioè può essere ciò che è, solo quando partecipa di tutti questi ambiti. L’esaurimento delle sue potenzialità si verifica a mano a mano che si diventa monodimensionali, concentrandosi solo su qualcuno di essi. Si tratta di un errore compiuto in buona fede. La madre di famiglia apprensiva, per esempio, dedicherà tutte le sue attenzioni al figlio e finirà con il sentirsi in colpa se pensa al suo lavoro che ha dovuto mettere da parte. La stessa cosa accadrà al padre che si sentirà indotto a dedicare ogni energia al lavoro, trascurando i figli. Si tratta di due esempi interscambiabili che rivelano una “attenzione escludente”. La soluzione, invece, consiste nella capacità della nostra attenzione di essere inclusiva, cioè di non ignorare tutte le altre “fette di torta”.
Una vita bilanciata prevede di riservare ogni giorno una attenzione consapevole a quelle dimensioni in cui la nostra umanità naturalmente si dispiega.
Tweet
La maggior parte delle persone tende a concentrare tutte le proprie ore di veglia sulle proprie priorità principali, cioè la fetta familiare e quella professionale.
Adottare la proposta di McNeff richiede prima di tutto di fare un inventario di ogni area della nostra vita. Bisogna identificare le fette dormienti, perché è dedicandosi ad esse che sarà possibile gradualmente ristabilire un equilibrio. L’obiettivo di questo esercizio semplice è di scattare una foto alla nostra vita in un determinato momento, stando bene attenti a tenere a bada quella parte di noi che è sempre pronta a giudicare negativamente ogni nostra azione.
“Purtroppo, non ho più tempo per questo” è la frase che diciamo a noi stessi quando ci accorgiamo che ci sono effettivamente delle cose che non riusciamo più a fare. Inizia così quel processo di rassegnazione che ci porta a limitare il nostro raggio d’azione in ambiti sempre più limitati.
Bisogna cercare di riconoscere frasi di questo tipo ed attuare delle contromisure. Rendersi conto che si è oberati o che uno dei settori della nostra vita sta fagocitando gli altri è il primo passo. Il secondo è di iniziare un piccolo cambiamento, da mettere in pratica ogni giorno: per esempio, anche solo trovare cinque o dieci minuti per meditare o fare qualcosa in cui ci sentiamo riconosciuti.
4. Conclusione
Immaginate un’orchestra sinfonica che si prepara a suonare. I musicisti aspettano che il direttore batta il suo leggio. Sollevano i loro strumenti. In risposta ai segnali del direttore, l’orchestra comincia a suonare come se fosse una “cosa” sola. Mentre i suoi membri suonano, il direttore comunica quando i violini devono prendere il comando, quando le trombe devono fare una pausa e così via, il tutto mantenendo il tempo.
Di fronte al gran numero di scelte possibili è come se fossimo il direttore d’orchestra di noi stessi.
Tweet
Allo stesso modo, tu sei il direttore della tua orchestra, e hai sette strumenti da dirigere. Per mantenere la profondità e la struttura della musica, hai bisogno che ogni strumento sia presente e abbia successo – ma alla fine, sta a te portare il tuo senso di armonia.
Non importa quanto tu sia occupato, vivere in armonia ti permette di gestire lo stress e affrontare ogni giorno con un atteggiamento più brillante. Tutto questo concretamente può significare che non perderai la calma in un ingorgo inaspettato e che le soluzioni ai grandi problemi appariranno più facilmente disponibili.
Soprattutto, il Metodo delle Sette Fette ti aiuta a prestare attenzione agli eventi della tua giornata, per assicurarti di non essere completamente assorbito dagli alti e bassi emotivi della vita quotidiana. Ricorda che non è necessariamente quanto tempo passi su ogni fetta che conta, ma la qualità di quel tempo e la forza del tuo impegno. Molte persone che abbracciano il metodo delle sette fette a lungo termine riferiscono che “la vita sembra più un viaggio”, mentre prima sembrava più un lavoro di routine. Alla fine, vivere nelle Sette Fette non solo vi farà sentire meglio; quando inizierete a sentirvi a vostro agio, lo faranno anche tutti quelli che vi circondano.